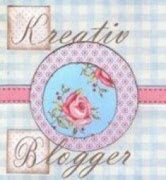ESSERE UN MALATO ORFANO DI DIAGNOSI
Quando la diagnosi non arriva
Quando una persona si ammala, in genere, il suo primo pensiero è cercare di dare un nome e una spiegazione ai sintomi che manifesta.
Molti non possono resistere alla tentazione di “capirci subito qualcosa” e quindi cercano su Google (cosa che in genere si traduce solo in inutili allarmismi), ma poi, per fortuna, in genere si passa al medico di base e poi eventualmente a specialisti ed esami.
Il punto cardine è sempre uno: capire cosa si ha per potersi curare. A volte è qualcosa di semplice e facilmente risolvibile, a volte qualcosa con cui poi si deve convivere a vita oppure che la vita può persino interromperla. In linea di massima, però, uno dei primi passi da fare è sempre quello di identificare il problema per capire come affrontarlo e, si spera, risolverlo.
Purtroppo non sempre questo processo va esattamente come vorremmo e la diagnosi, che dovrebbe essere la nostra bussola nel nostro percorso di malattia, non c’è e ci lascia senza una direzione chiara da seguire.
La catena logica “sintomo-medico-diagnosi-cure-miglioramenti-guarigione” (che in quasi tutte le malattie è il filo conduttore, tranne in quelle in cui miglioramenti e guarigione non sono possibili) si spezza ancora prima di cominciare.
Anche se molte persone possono capire che di una malattia si può morire (avendo magari purtroppo anche in mente casi di tumori o altre malattie orribili e gravissime), quasi nessuno pensa che si possa star male senza nemmeno riuscire a dare un nome a ciò che si ha e quindi senza poter nemmeno tentare terapie e approcci corretti per affrontare il problema. Bloccati per mesi, anni, decenni… una vita intera, in un limbo senza risposte.
È un’immensa area grigia quella di chi soffre di patologie che non hanno diagnosi, noti anche come “orfani di diagnosi”. Spesso non trovano la loro diagnosi perché affetti da malattie rare, che quindi vengono scoperte solo dopo moltissimi anni di peregrinazioni di ospedale in ospedale, di specialista in specialista, di sospetto in sospetto. Altrettanto spesso restano senza diagnosi e basta, perché affetti da patologie troppo rare o perché mai finiti in mani giuste. Gli orfani di diagnosi sono un fenomeno silenzioso, spesso ignoto ai più, spesso poco considerato, proprio perché distante dalla vita della maggioranza della popolazione.
Oggi sono stata invitata qui per parlarvi delle malattie orfane di diagnosi o, meglio, di cosa significa essere un malato orfano di diagnosi. Non sono un medico, ma ho comunque 15 anni di esperienza sul campo e quindi spero di potervi almeno far intuire cosa è la vita con una malattia orfana di diagnosi.
Io ho iniziato ad avere sintomi nel 2006; non avevo ancora compiuto 15 anni e ora ne ho 30. Metà della mia vita è stata una ricerca, un tentativo di dare una spiegazione a una variegata costellazione di sintomi che continuano a peggiorare e mi avvelenano la vita. Non conduco l’esistenza che immaginavo da ragazzina, non ho potuto portare avanti i sogni che avevo, perché, continuando a peggiorare, progressivamente ho dovuto ridimensionare i miei sogni, adattarli come creta alle mie nuove condizioni di vita. Come un serpente, ho capito come cambiare pelle, reagire ed essere resiliente (anche se la pelle nuova è molto delicata all’inizio e sono più fragile e indifesa). Ho imparato a lasciare la me che ero per aiutare a far sopravvivere la me che pian piano stavo e sto diventando. Avere una malattia cronica è un po’ come avere le ali più piccole di quanto vorremmo e doverci fare i conti ogni giorno, quando tentiamo di spiccare il volo verso i nostri obiettivi.
Per i primi anni, ero assolutamente convinta che avrei trovato una diagnosi e mi sarei potuta curare, per questo andavo avanti ostinatamente con i miei progetti, pur faticando molto di più dei miei pari, perché tutto era orientato e rivolto al “quando sarò guarita”. Ci ho messo davvero tanti anni a capire che probabilmente non succederà mai e che dovevo abbandonare la vecchia me e i miei vecchi sogni, se volevo costruirne di nuovi e a mia misura, se non volevo vivere nella frustrazione di sentirmi continuamente incapace di ottenere ciò che volevo. Ora ho una serenità e una pace dentro che anni fa sarebbe stata davvero impensabile, quando volevo far finta di non essere malata, quando mi ostinavo a pretendere da me molto più di quanto sarebbe stato lecito chiedermi anche da sana.
Dopo i primi circa 7 anni di dolore e sofferenza continua, è arrivata la prima “diagnosi” di “sospetta fibromialgia”. La fibromialgia non è un patologia ma una sindrome (cioè un’etichetta che racchiude un insieme di sintomi). Al momento mi era sembrato di aver finito il mio viaggio, di aver dato un nome a tutto il mio dolore ma… era solo la punta dell’iceberg, una minuscola punta che però decretava che non sarei mai potuta guarire, che ci avrei dovuto convivere. Lì il mio obiettivo di guarire e riprendere la strada che volevo è stato calpestato, travolto da un’ondata di realtà, ma non mi sono arresa. Anzi, pensavo che sapere contro cosa stavo combattendo mi avrebbe dato finalmente una direzione. Così non è stato.
Ho continuato la ricerca della mia diagnosi e ancora non si è conclusa. Al momento è certo solo che ho questa sindrome dolorosa diffusa e una costellazione variegata di sintomi che riguardano un po’ tutto il corpo (articolazioni, polmoni, cuori, intestino, stomaco, pelle, occhi…). Ogni tanto un nuovo sintomo fa capolino, ogni tanto qualche vecchia conoscenza peggiora e ancora nessuno è riuscito a mettere insieme i pezzi del mio puzzle. Si è scoperto solo che ho un’asma grave (che non è una forma grave di asma ma una malattia a sé) eppure, nonostante questo, nemmeno i problemi respiratori sono tutti etichettati e trattati adeguatamente (aggiungiamoci che sono farmacoresistente e ho effetti collaterali sempre spropositati). Si sono scoperte anomalie qua e là nelle decine e decine di esami (un po’ di reflusso, tachicardia cronica, dermatiti, iperlassità legamentosa…), ma niente che possa dare un nome e una spiegazione al quadro generale o che possa giustificare la gravità dei miei sintomi.
Il 2021 è stato un anno strano. È iniziato con l’attesa di una biopsia e poi del relativo referto che sembrava dover spiegare ogni cosa e darmi finalmente una diagnosi. La sospetta diagnosi era così calzante con la mia situazione che il neurologo che mi seguiva non aveva alcun dubbio: la biopsia serviva solo a conferma. Peccato che poi sia risultata negativa, ributtandomi nel girone degli orfani di diagnosi. Anche il medico si è visto crollare le certezze e mi ha detto che a quel punto poteva solo consigliarmi di cercare una terapia del dolore e tirare avanti perché difficilmente avrei trovato una risposta.
Ero al buio, come se non ci fossero più strade da tentare, dopo 14 anni a combattere contro medici per i quali era più semplice dire che ero “pazza”, “esaurita”, “depressa”, “troppo emotiva” che ascoltarmi, in quel momento mi sembrava di non avere più voce, prospettiva o speranza. Dovevo solo “accontentarmi e tirare avanti” come sostenevano? Non era tollerabile per me come prospettiva, io avevo bisogno di capire cosa mi stava succedendo e non ero disposta a starmene semplicemente in silenzio, solo per non dare fastidio a medici che prima promettevano speranze, diagnosi e cure e poi al minimo intoppo erano pronti a dire che la colpa era mia, che inventavo tutto ed esageravo.
Io sono una persona luminosa e in quel buio non ci volevo stare, per fortuna avevo ancora una carta da giocarmi: una compagna di sventura (anche lei orfana di diagnosi), poi diventata amica, mi ha parlato di un ambulatorio in cui un caso come il mio poteva trovare ascolto e voce. È così che ho conosciuto l’Ambulatorio Malati Orfani di Diagnosi del San Martino di Genova e due medici straordinari, il dottor Cocchiara e il dottor Fancellu, che mi stanno seguendo da aprile con una dedizione, un rispetto e una cura che va oltre ogni mia aspettativa. Ancora non ho le mie risposte, ma, da quando li ho conosciuti, non sono più stata abbandonata: loro seguono e coordinano ogni mio esame e ogni mia visita, raccolgono tutti i referti; sono il faro e l’indirizzo, sono la mia bussola, anche se la diagnosi ancora non ce l’ho (ma gli esami e gli accertamenti proseguono).
E se vi state chiedendo perché fare nomi e cognomi, se vi sembra una pubblicità… no, non lo è, ma sono straordinari e non lo faccio per far contenti loro (che tra l’altro penso non leggeranno mai queste mie parole). Lo faccio perché magari a leggere questo post c’è qualcuno che cerca risposte da una vita, che il sistema sanitario tratta come “un inutile spreco di risorse” (come sono stata definita io una volta da un medico) e che potrebbe ritrovare speranza sapendo che c’è almeno un posto pronto ad accoglierlo, che c’è almeno qualcuno disposto ad ascoltarlo. Un grande grazie va a Deborah Capanna, la fondatrice di questo Ambulatorio, anche lei affetta da molte gravi patologie, non tutte diagnosticate. Dobbiamo a lei se oggi io e tanti altri possiamo definirci “orfani di diagnosi” invece che essere trattati come “malati immaginari” o peggio.
Quindi, sì, mi sono permessa di fare dei nomi, anche a costo di trasformare questo post sull’essere malati orfani di diagnosi in qualcosa di diverso da quello che doveva essere originariamente, perché
ho il dovere civico e morale di gettare una corda a chi si trova disperso nell’oceano del dolore senza risposte. Questa corda è stata lanciata a me quando non avevo altri appigli e ora voglio rilanciarla anche io, ma non mi dilungo, trovate tutte le informazioni andando sul sito "Comitato i malati invisibili onlus"
Ora cerco di riprendere il filo del discorso, lo prometto, per tutti quelli che invece sono qui a cercare di capire cosa significa essere un malato orfano di diagnosi e si aspettano che sia io a spiegarlo…
Be’, non è facile, senza dubbio, come si può cercare di far comprendere cosa significa soffrire ogni singolo giorno senza sapere nemmeno cosa ci sta causando tutta quella sofferenza? Senza sapere come sarà il futuro? Sono sincera, è difficile spiegarlo, perché senza averlo vissuto è una cosa completamente distante dalla realtà quotidiana di moltissime persone (per loro fortuna). Se devo essere del tutto onesta, io non riesco a ricordare come era non essere malata, non provare dolore. Non lo dico per cercare compassione, ma proprio per far capire che cercare di spiegare una vita di dolore è difficile come cercare di spiegarne una senza. A volte mi sorprendo a pensare: “Ma come fa quella persona a stare lì in piedi, senza appoggiarsi, ma non è stanca?” oppure “Ma oggi ha fatto la spesa, davvero poi riesce ad andare anche da un’altra parte?”. Poi d’improvviso mi ricordo che non è assurdo per una persona sana, che non sono dei super eroi, semplicemente sono alleggeriti dal fardello del dolore cronico, che io non posso posare nemmeno per cinque minuti. Però, spesso, ecco che me ne dimentico, e guardo gli altri come se fossero me e mi stupisco, mi stupisco di quanto tutto appaia semplice, naturale. Ecco, essere malati cronici è così: dimenticare come era la vita prima, essere così abituati a soffrire da non riuscire nemmeno a ricordare che per tanti il dolore è qualcosa di saltuario, spesso da mettere a tacere in pochi minuti con un analgesico da banco.
Vivere con il dolore ti cambia, per sempre. Non ti rende migliore, come vogliono farvi credere nei film, anzi, spesso cerca di distruggere tutto ciò che di bello si era o si poteva diventare. Sta a noi non renderlo possibile, accettare la malattia, continuare a evolvere, crescere, sperare, cercare risposte, terapie, cure…
Lottare contro la malattia ad armi impari, perché nemmeno sappiamo cosa sia o dove colpirà la prossima volta o come e quanto peggiorerà, come saremo tra un mese, un anno, un decennio... Io nel 2020 stavo incredibilmente meglio di come sto ora, l’anno appena finito mi ha “regalato” tanti peggioramenti ed è difficile capire come sarà il prossimo. So solo che io sono pronta ad affrontare ciò che verrà e, come spero sempre, un giorno avrò la mia diagnosi (o le mie diagnosi).
Nel frattempo voglio ricordare a tutti quelli come me che nessuno ha il diritto di farvi sentire sbagliati, inutili o esagerati. Nessuno ha il diritto di definirvi “depressi” se ogni tanto siete sopraffatti dalla malattia e spaventati o “ansiosi” perché vi preoccupa il vostro futuro. Ansia e depressione possono essere diagnosticati da uno psichiatra e possono essere primari o secondari alla vostra patologia cronica. Se ci sono, vanno curati e trattati come ogni patologia, ma… non devono diventare le etichette di ogni ortopedico, neurologo, pneumologo e tutti i -logo del mondo, solo perché non hanno il coraggio di dire che non sanno darvi risposte. Non c’è nulla di male ad avere una patologia mentale, ma le parole in campo medico hanno un peso: “ansia” non è “preoccupazione”, “depressione” non è “tristezza”. Non lasciatevi mai schiacciare sotto il peso di diagnosi fatte di pancia da medici con le spalle al muro, dopo tanti esami pronti solo a smentire le loro sospette diagnosi. Affidatevi a medici competenti, disposti ad ascoltarvi e a credervi e non arrendetevi. Mai. Purtroppo ci siamo passati in tantissimi… ci sarà sempre qualche medico pronto a darvi colpe che non avete, a trattarvi male ai limiti della decenza, ma ci sono anche medici straordinari: vanno solo cercati un po’.
Mi sono dilungata troppo (non a caso ci sto scrivendo ben due libri sopra… chissà se mai troverò il coraggio di finirli). È un argomento complesso e condensarlo in poche righe è molto difficile. Ho parlato poco di me, tutto sommato, ma se avete domande, risponderò volentieri nei commenti e anche in privato, essendo argomenti di cui qualcuno potrebbe non aver voglia di parlare in pubblico (potete scrivermi qui:
tamericiromina@gmail.com).
Ringrazio Daniele per avermi ospitata qui e anche per aver deciso di portare avanti una rubrica dedicata alle malattie rare: c’è davvero tanto bisogno di informare sul tema. Grazie ancora a lui e a voi, se siete arrivati fin qui.
Romina Tamerici